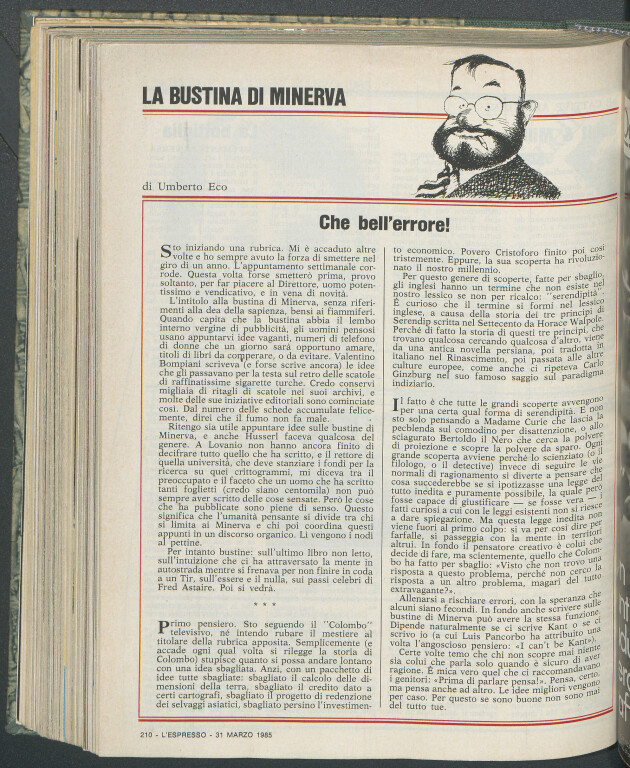
Album "La Bustina di Minerva"
In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale della raccolta di articoli La Bustina di Minerva di Umberto Eco (Bompiani, 2000), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito uno spunto per uno dei testi contenuti nel volume. Questo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non c’è quindi nessuna pretesa di una presentazione esaustiva dei molti argomenti e materiali che la varietà caleidoscopica degli articoli potrebbe suggerire. La scelta di quali percorsi esplorare o ignorare si è basata su motivazioni anche episodiche e dettate dall’interesse dei lettori e dalle discussioni che il gruppo di lettura ha sostenuto negli incontri precedenti. Più ancora che per le galleries precedenti anzi, in questo caso la natura frammentaria del testo ha suggerito una metodologia di ricerca spesso guidata dal caso e dalla serendipità, che restituisce un lavoro frammentario e composito, che speriamo possa rendere conto della struttura testuale e concettuale dell’opera da cui siamo partiti.
Delle citazioni non forniremo la pagina precisa ma il titolo dell’articolo da cui sono tratte. Questo rende più semplice identificare la citazione nelle diverse edizioni pubblicate della Bustina e la brevità degli articoli stessi (poco più di due pagine per la gran parte dei testi) rende molto semplice rintracciarvi il passo citato.
I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.
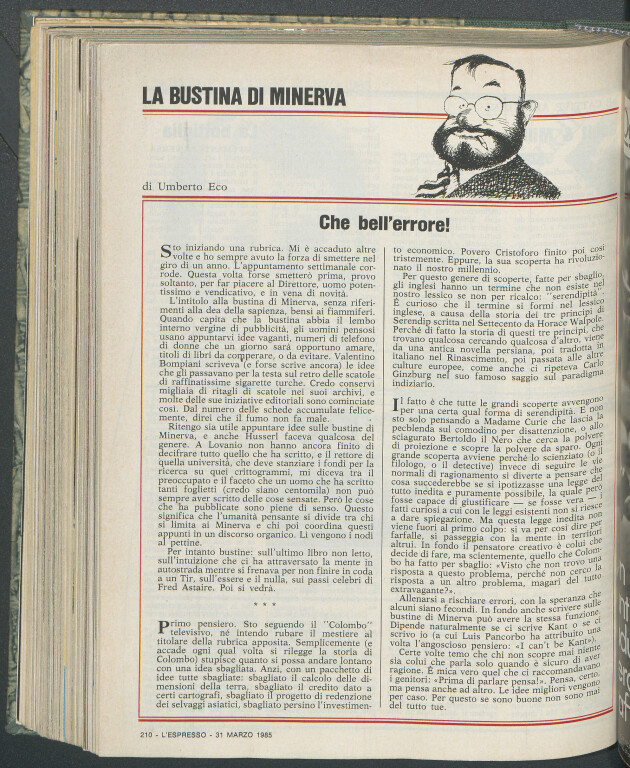
La prima Bustina: Che bell'errore! (31 marzo 1985)
Come già detto, il volume uscito nel 2000 contiene solamente Bustine degli anni Novanta. Non riporta quindi la prima “puntata” della rubrica, uscita su «L’Espresso» del 31 marzo 1985, annunciata sia sulla copertina che nell’indice del fascicolo da un piccolo riquadro in cui compare lo stesso ritratto di Eco, firmato da Tullio Pericoli, che accompagna anche il testo.
In questa prima Bustina l’autore spiega la scelta del titolo:
«L’intitolo alla bustina di Minerva, senza riferimenti alla dea della sapienza, bensì ai fiammiferi. Quando capita che la bustina abbia il lembo interno vergine di pubblicità, gli uomini pensosi usano appuntarvi idee vaganti, numeri di telefono di donne che un giorno sarà opportuno amare, titoli di libri da comperare, o da evitare. [...] Ritengo sia utile appuntare idee sulle bustine di Minerva [...]: sull’ultimo libro non letto, sull’intuizione che ci ha attraversato la mente mentre si frenava per non finire in coda a un Tir, sull’essere e il nulla, sui passi celebri di Fred Astaire. Poi si vedrà».
Continuando la lettura oltre questa breve introduzione si ritrovano già un paio di temi interessanti.
Il primo spunto di discussione nasce da uno sceneggiato TV dedicato a Cristoforo Colombo. Eco continua quindi a tenere al centro della propria attenzione, fra le altre cose, i media di massa, come ben sappiamo dopo la lettura che abbiamo fatto di Apocalittici e integrati.
Ma il cuore del discorso di questo primo articolo riguarda il concetto di serendipità - di cui l’avventura di Colombo appunto è caso paradimagtico - cioè l’idea che spesso una scoperta importante nasce per caso e da un errore di valutazione compiuto dal ricercatore. Scrivere questa rubrica può avere per lui la stessa funzione, può essere lo spazio in cui «Allenarsi a rischiare errori, con la speranza che alcuni siano fecondi».
Nel nostro piccolo ci siamo accorti che partire per una ricerca documentaria sulla base dei testi raccolti nel volume - frammentari, vari, così diversi l’uno dall’altro - può portare a ricerche in cui si concretizza proprio il concetto di serendipità, l’esperienza stimolante di trovare «qualcosa cercando qualcosa d’altro». Lo vedremo, nel corso di questa gallery. Eco dà un esempio di queste piccole avventure di ricerca guidate dal caso in Trionfo e tramonto della stroncatura, Bustina del 1999 in cui racconta che, cercando un suo articolo del 1991 sui tabù linguistici, gli era capitata fra le mani «un’altra Bustina, del novembre 1986» in cui si parlava del fatto che fra le recensioni dei giornali non si incontrassero più delle belle stroncature. E quest’idea aveva preso il sopravvento, portando all’elaborazione di un nuovo testo sul tema.
Umberto Eco, Che bell’errore!, «L’Espresso», XXXI, 31 marzo 1985, p. 210.
